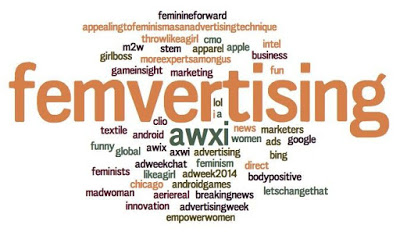‘Il ‘femvertising” è la pubblicità femminista e critica rispetto ai modelli di rappresentazione della donna nella comunicazione commercia, sulla cui coerenza e genuinità d’intenti sono stati avanzati molti dubbi e riserve. Quanto può essere efficace un’azione di critica culturale e sociale, se a condurla sono grandi marchi della moda o della cosmetica, impegnati a produrre utili?
Le aziende, spesso si trovano a dover essere più realiste e concrete di governi o parlamenti. Devono vendere i loro prodotti, fare in modo che il loro marchio goda di buona popolarità ed evitare di rischiare di inimicarsi fasce di pubblico che potrebbero non acquistare più la loro merce. Forse per questo, in alcuni momenti storici, sono state loro ad anticipare le istituzioni nell’occuparsi di questioni che vengono ritenute scabrose, ma che per convenienza economica, risultava opportuno affrontare. Da qualche anno si parla di ”femvertising”, di strategie di comunicazione commerciale accomunate da un esplicito piglio femminista. La lista è lunga e riguarda diversi settori merceologi: dalla cosmesi, ai prodotti da bagno, è evidente lo sforzo di proporre (e vendere) un modello di donna che si allontana dagli stereotipi di bellezza che dominano la pubblicità, proponendo volti e corpi comuni e puntando sulla loro normalità per attirare i consumatori. Ma è facile inciampare nella contraddizione e nelle conseguenti critiche, se ad esempio un grande marchio di cosmetici, vuole incitare le donne ad essere loro stesse, ma contemporaneamente deve spingerle ad acquistare prodotti che ne mascherino l’età o le piccole imperfezioni.
Il trend è partito dagli Stati Uniti, la patria deputata dell’advertising, dove il vento del #metoo, delle battaglie per il ”women enpowerment” e in generale, della ”politic correctness”, è arrivato a soffiare sulle finestre ai piani alti delle grandi agenzie di comunicazione. E’ accaduto anni fa nelle sedi delle più importanti case di moda (Christian Dior, Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, tanto per citare alcuni nomi) quando si è deciso che in passerella o sui set fotografici non si dovessero più fare sfilare o posare modelle anoressiche e in età puberale. Recentemente Gucci ha lanciato la sua campagna ”Chime for change”, utilizzando lo slogan ”To gather together” a sostegno della diversità di genere.
Ma potremmo aggiungere precedenti campagne gay friendly, come quella della Findus, della McDonald o di marchi di abbigliamento come GAP, Banana Republic o Benetton, azienda pioniera nel portare nella sua comunicazione messaggi di tolleranza e di antirazzismo. Per non dimenticare il recente spot della Gillette, in cui per la prima volta si è rinunciato allo stereotipo del macho perfettamente sbarbato, per fare posto all’immagine di uomini che per una volta non sembrano dei narcisi imbottiti di testosteroni. Tutto molto bello, si vorrebbe dire. E ci piacerebbe sapere che queste campagne hanno un reale effetto nel diminuire i nostri pregiudizi nei confronti di varie categorie, le donne, gli omosessuali o chi viene discriminato per il suo aspetto. Forse inscrivere tutte queste iniziative nella categoria del ”brand washing”, di tutte quelle attività che le aziende svolgono per mostrarsi preoccupate del benessere dei loro potenziali clienti o del pianeta in cui vivono, potrebbe sunare ingiusto e ingeneroso. Forse è però inevitabile sospettare che di questo si tratti.
Tornando al ”femadvertising”, il timore è che si lasci alle aziende, il cui legittimo e principale obiettivo è produrre degli utili, il compito che dovrebbe invece essere assunto da altri, dalle istituzioni, in primo luogo o dai mezzi di informazione a proprietà pubblica per fare un altro esempio. Dietro queste campagne ci può essere una reale possibilità di miglioramento della nostra società, ma spesso c’è semplicemente la volontà di riposizionarsi sul mercato, sfruttando a proprio vantaggio temi delicati come quello della discriminazione, costruendo attorno ad essi iniziative dall’alto valore emozionale, ma necessariamente dirette a garantire agli investitori il profitto che legittimamente questi si aspettano di ricevere. Da che mondo è mondo, gli affari sono affari e alla fine le aziende interessate non valuteranno mai le campagne se e quanto hanno trasformato i consumatori in persone migliori, ma se quei consumatori a cui si sono rivolti, hanno effettivamente s peso il loro denaro per comprare i prodotti esposti in vetrina. Tutto il resto, alla fine, temiamo conti ben poco.